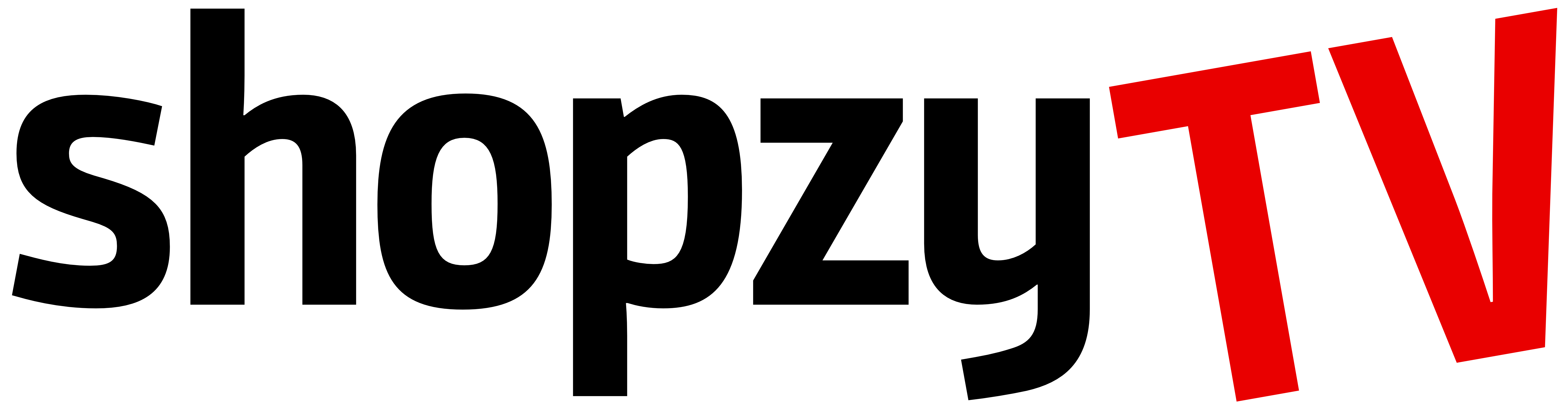Era un po’ l’amico di tutti, Gianni Minà. Non solo di Maradona, di Fidel o di Cassius Clay. Bucava il video della tv vecchia, quella con le manopole, quando mi incollavo a guardare le sue creature, Dribbling e Blitz, che già mixavano sport, costume e sociale. Era la fine degli anni ’70 e l’inizio degli 80. E sono cresciuto con un suo tormentone. Una frase che ancora oggi torna utile quando sei su un palco e davanti a centinaia di persone cadi in un’incomprensione di scaletta, è come l’intervento disperato di un difensore che evita un gol avversario rifugiandosi in calcio d’angolo, così quel provvidenziale è il bello della diretta oggi assumerà meno prosaicità e maggiore lirismo.
Per chi ama il mondo ispanoamericano Gianni Minà è una sorta di totem. Se ne è andato a 84 anni, vissuti intensamente, probabilmente facendo sempre quello che desiderava, raccontando il mondo con la semplicità che lo contraddistingueva, compiendo gesta memorabili, senza filtri, con un’intensità unica.
Andare a rivangare gli episodi in cui Gianni Minà è stato un protagonista universale per il giornalismo, l’informazione e l’intrattenimento oltre che per l’approfondimento è un esercizio di stile che rende però giovane la memoria. Ho scritto un romanzo sull’orrore dei desaparecidos e ho toccato con mano la tragedia di chi ancora si porta dietro cicatrici che non saranno mai bianche, eppure Gianni Minà durante una conferenza stampa di presentazione del Mondiale di Argentina 78, quello dove anche i grandi artisti si sono genuflessi al potere, azzardò una serie di domande scomodissime all’ammiraglio Carlos Alberto Lacoste, all’epoca grande burattinaio del comitato organizzatore e membro della dittatura della junta militar: che fine fanno i giovani che salgono sulle Ford Falcon? Tentò anche di intrufolarsi nelle pieghe della società argentina per avere risposte a quelle domande che l’Occidente vigliaccamente non si poneva, condannando a morte un Paese latinoamericano che per metà era spagnolo e per l’altra metà italiano e che aveva alzato presto la bandiera della globalizzazione accogliendo in nome della vita chiunque ancor prima che la globalizzazione fosse inventata. La Rai, per evitare incidenti diplomatici ma anche per salvargli la pelle, lo ficcò su un aereo e lo fece rimpatriare. Ma quell’amore per gli ultimi, per gli sconfitti, per i romantici, per i sudacas era ormai germogliato, creando una rivista che ancora oggi vive sul web, Latinoamerica e tutti i Sud del mondo.
C’è però un episodio, più mondano, più da dolce e bella vita, che ti strappa sorrisi infiniti, cioè quella mitica cena da Checco Er Carettiere a Roma in cui a tavola si siedono Sergio Leone, Robert De Niro, Muhammed Alì e Gabo Márquez. E, ovviamente, lui, Gianni Minà, gran cerimoniere. Poi, le interviste a Fidel o al D10s sono chiacchierate tra amici rese pubbliche, seppure l’animo indagatore lascia talvolta spazio all’indulgenza come nel caso del dittatore cubano.
E poi Minà corona il sogno di una vita, come nobile era l’arcobaleno che portò ‘Fuser’ a compiere un viaggio meraviglioso in SudAmerica con una scassata Poderosa insieme al suo fedele amico Mial. E sì, parliamo di quella mitica avventura intrapresa in motocicletta nel 1952 dal laureando in medicina Ernesto Guevara e da Alberto Granada, biologo, amici per la pelle, che viaggiano in un Continente alla scoperta delle sue vere cicatrici, sempre aperte, ancora oggi non rimarginate, come direbbe Eduardo Galeano, altro amico di Minà. Minà si prende il lusso di ripercorrere con l’80enne Alberto Granado tutte le tappe coperte all’epoca con il Che, tanto che firmerà il lungometraggio In viaggio con Che Guevara (2003), che gli varrà la collaborazione per la stesura del film I diari della motocicletta diretto da Walter Salles e prodotto da Robert Redford. E già, si corre, si vive e si saluta. Del resto, è il bello della diretta.
Gian Luca Campagna (giornalista e scrittore)